Fonte: Limes
La vera fase due del piano Trump
Israele e Hamas rompono la tregua che nessuno dei due vuole davvero. Quattro gli snodi fondamentali della fase attuale: conflitto a bassa intensità, tensioni interne allo Stato ebraico, purghe del movimento islamico e tensioni in Cisgiordania. Il vero nemico è la Turchia che brama il protettorato su Gaza.
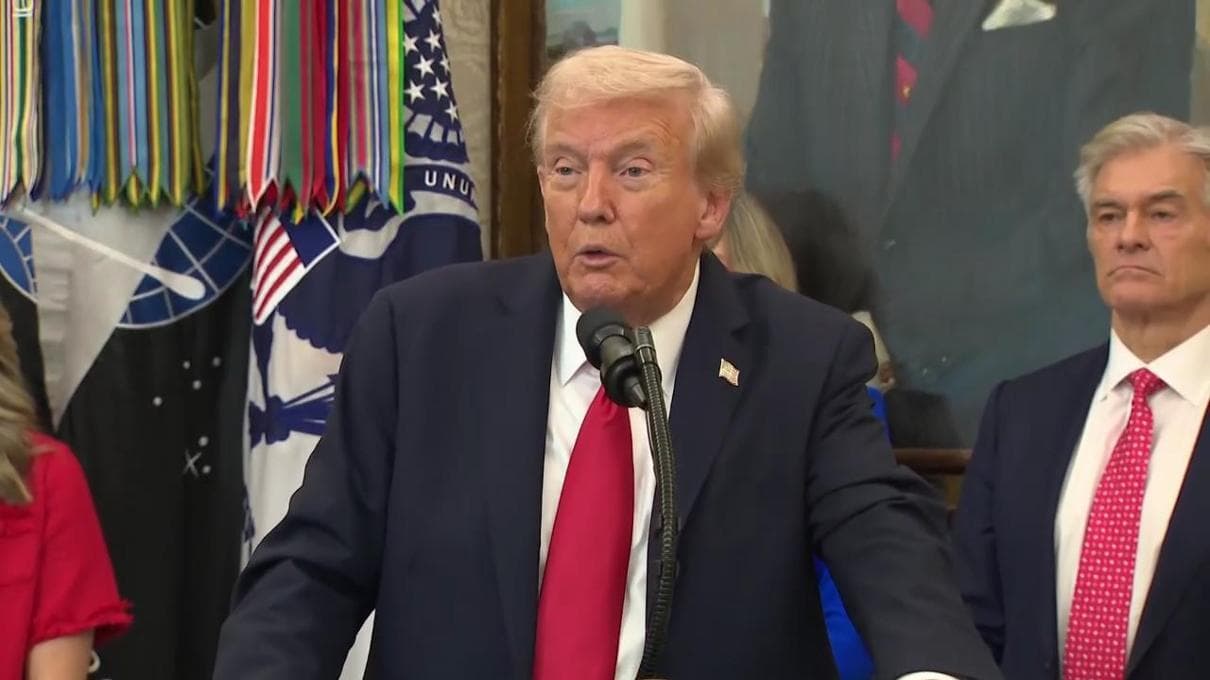
La mattina del 19 ottobre si è rotta la tregua dei dieci giorni imposta da Donald Trump a Binyamin Netanyahu. Milizie palestinesi, con cui Hamas nega di avere rapporti, hanno attaccato i soldati israeliani nella Striscia con cecchini e armi anticarro, uccidendone due. La risposta delle Forze di difesa israeliane (Idf, Tzahal) è arrivata nel pomeriggio, ed è culminata con la distruzione – stando a quanto Tzahal scrive su X – di “depositi di armi, postazioni di tiro, cellule terroristiche e altre infrastrutture” site nella zona Sud della Striscia. Soprattutto, le Idf avrebbero “colpito e smantellato 6 chilometri di infrastrutture terroristiche sotterranee”. Equivalenti, stando alle stime più attendibili, all’1,2% dell’estensione del sistema di tunnel che si snoda sotto e oltre Gaza.
L’interruzione del cessate-il-fuoco da parte di Hamas, poi ripristinato in serata dalle Idf a seguito degli attacchi su Gaza, ha ovviamente riattivato i bollenti spiriti della politica israeliana. Mentre Bibi, silente, si confrontava con il ministro della Difesa Katz e col capo di Stato maggiore Zamir, Smotrich e Ben Gvir invocavano la ripresa della guerra “al massimo livello di forza”, con l’obiettivo di concludere quanto iniziato il 7 ottobre del 2023: eliminare Hamas nella sua totalità e procedere con l’“immigrazione” di coloni ebrei nella Striscia.

Tutto ampiamente prevedibile. Che la tregua tra Israele e Hamas facesse acqua da tutte le parti era infatti il segreto di Pulcinella, così come non era difficile immaginarsi che essa si sarebbe incrinata a seguito del rilascio degli ostaggi (quelli vivi) e a partire dall’inizio delle trattative per la seconda parte del piano Trump. Ovvero quella che prevede l’impossibile, cioè il disarmo volontario (sic) di Hamas, l’ingresso nella Striscia di una forza di stabilizzazione internazionale e l’insediamento del Board of Peace targato Trump-Blair.
Sulla Terra, la “fase due” del piano Trump – l’unica davvero possibile e destinata a durare – ha tutta un’altra faccia. Essa è infatti iniziata ieri, e ruota attorno a quattro snodi fondamentali:
1) Guerra continua e a bassa intensità tra Israele e milizie varie, da cui Hamas può dissociarsi ma che lo Stato ebraico considera congruenti con l’organizzazione palestinese, come da apposita proposta elaborata da Itamar Ben Gvir e assecondata da David Zini, novello capo dello Shin Bet. Il tutto nonostante Trump, che per limitare le potenziali escalation e cercare di tenere in vita il suo piano si affretta a dichiarare che le milizie responsabili dell’attacco “probabilmente non sono legate ad Hamas”.
2) Aumento delle tensioni interne allo Stato ebraico sul da farsi, con le Idf – appoggiate dagli Usa – restie a entrare nei tunnel, i sionisti religiosi che invece gli chiedono di farlo e Bibi che danza su una corda sempre più sottile, cercando di tenere insieme il governo, l’esercito e l’America. Dei cui 200 soldati inviati in Israele per controllare la tenuta della tregua si sono perse le tracce.
3) Purghe operate da Hamas nella Striscia, dove brigate di palestinesi si vendono al miglior offerente. Addirittura cambiando il nome, come nel caso del gruppo armato guidato da Yasser Abu Shabab, da qualche ora rinominatosi Israeli-backed Popular Forces. A scanso di equivoci.
4) Approfondimento delle tensioni in Cisgiordania, luogo di bellum omnium contra omnes in cui sia Hamas sia i coloni stanno aumentando l’intensità delle loro operazioni – così legittimandosi a vicenda. In questa terra di tutti dunque di nessuno anche gli arabi israeliani – più realisti del re – collaborano attivamente con lo Stato ebraico e con l’Autorità nazionale palestinese alla cattura di altri palestinesi. Se Israele non fosse in pieno delirio, non dovrebbe neppure fare il “lavoro sporco” (Merz). A tagliare l’erba ci penserebbero infatti direttamente i suoi “nemici divini” (Zini).

Insomma, quello a cui stiamo assistendo non è esattamente lo svolgersi del piano Trump. E tuttavia, il paradosso è che questa “fase due” mette Hamas e Israele, non a caso assenti al vertice di Sharm el-Sheikh, molto più d’accordo dei venti punti presentati dal tycoon.
Per Hamas, la guerra a bassa intensità è infatti una manna dal cielo. Col sistema di tunnel pressocché intatto, l’organizzazione può colpire le Idf anche – come è successo ieri – al di là della linea gialla, sollecitando il punctus dolens dello Stato ebraico, ovvero la differenza di vedute tra Idf e alleati di Bibi.
Le operazioni di Hamas segnalano infatti in maniera plastica come, senza distruzione dei tunnel, non sia possibile dichiarare vittoria o pace. Il punto è che entrare nei sotterranei di Gaza è esattamente ciò che Tzahal non vuole fare e che invece Smotrich e Ben Gvir non vedrebbero l’ora di (fargli) fare. Il risultato sono le infinite polemiche e il caos nello Stato ebraico. Potenzialmente foriero di definitiva rottura tra catena di comando civile e militare.
E tuttavia, anche per Netanyahu l’attuale congiuntura offre delle opportunità. Intanto, per tenere buoni Smotrich e Ben Gvir, combattere ogni tanto è meglio che non combattere affatto. Inoltre, quando le azioni di Hamas contraddicono il suo piano, Trump tende ad aprire inaspettate finestre d’opportunità allo Stato ebraico. A volte basta un post su Truth, come quello con cui il tycoon ha specificato che se Hamas non si fosse disarmato la guerra avrebbe potuto riprendere. Detto, fatto.
Soprattutto, però, la “vera” fase due del piano Trump permette a Israele di trascendere le questioni tattiche e concentrarsi su quelle strategiche. Ovvero la Cisgiordania e, ancora più importante, la Turchia.

Del primo scenario abbiamo già detto. La stretta su Gaza sta infatti portando Hamas ad ammassare uomini e mezzi nella regione, dove comunque era già presente. Il risultato è che Israele approfondisce la sua presenza nell’area, sia a livello militare sia infrastrutturale. Il progetto E1 (si veda la carta “Gerusalemme Est + E1”), che collegherà Gerusalemme est a Ma’ale Adumim e all’area C, taglia infatti in due la già coriandolizzata Cisgiordania (si veda la carta “Oggi Cisgiordania domani Giudea e Samaria?”), creando due macroregioni circondate da Israele e composte da tanti isolotti (si veda la carta “I 6 isolotti di Smotrich”), anch’essi a loro volta circondati dallo Stato ebraico. Sorta di matrioska securitaria che rende de facto impossibile qualsiasi forma di statualità palestinese.
La questione essenziale è tuttavia quella turca. Netanyahu ha spiegato che non è andato a Sharm el-Sheikh perché impegnato a celebrare la festività di Simchat Torah. Non è così. In realtà, il primo ministro israeliano non si è recato nella località marittima egiziana perché Recep Tayyip Erdoğan ha minacciato Trump di invertire la rotta del suo aereo e di tornarsene in patria. E il presidente turco aveva un duplice motivo per evitare Netanyahu.
Primo. Il piano del tycoon, che prevede l’invio di uomini di Ankara (spie) nella Striscia per trovare i corpi senza vita degli ostaggi, trasformerebbe Gaza in una sorta di protettorato turco. Affaccio su Suez, sulla Patria Blu e soprattutto su Cipro, dove Atene e Gerusalemme si fanno gli occhi dolci. Erdoğan non aveva alcuna intenzione di trattare con il premier israeliano su questo, dunque riteneva la sua presenza inutile se non dannosa.
Secondo, e conseguente. Se Trump ha cercato in ogni modo di salvare Bibi, Erdoğan le sta provando tutte per farlo crollare. E siccome sa che Netanyahu può sopravvivere solo se continua la guerra, il presidente turco non voleva che la presenza del primo ministro israeliano in Egitto impedisse l’invio di suoi uomini nella Striscia. Perché un conto è colpire Hamas e i civili palestinesi, un altro è assumersi il rischio di colpire uomini della Turchia. Se Ankara dovesse dispiegare personale a Gaza, Netanyahu dovrebbe procedere con molta più cautela nella Striscia, magari sopportando qualche scorribanda delle milizie palestinesi o, comunque, rispondendo in maniera decisamente più leggera. Con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta interna, dato che Smotrich e Ben Gvir non prenderebbero bene la cautela del primo ministro – specie se motivata dalla presenza della Turchia in uno spazio che i ministri del sionismo religioso considerano parte della Terra d’Israele.

E dunque la ripresa delle ostilità, sollecitata da Hamas ma citofonata da giorni, è – per dirla in pentagonese – un virtual preemptive strike israeliano contro la presenza turca a Gaza.
È una questione di tempi. Si tratta di attaccare la Striscia prima che vi arrivino gli uomini di Erdoğan per evitare che vi arrivino. Tutta la fase due, la vera fase due, va dunque letta anche come il tentativo israeliano di rimandare quanto più possibile l’arrivo dei turchi a Gaza, impedendo che si verifichino le condizioni affinché ciò avvenga e sperando che Hamas riesca – impresa ai limiti dell’impossibile – a trovare i corpi degli ostaggi morti senza la longa manus di Ankara. Così da legittimare il niet all’aiuto offerto da Erdoğan senza tuttavia imbarcarsi, di nuovo, in una guerra fuori tutto e dentro i tunnel.
In questo scenario, Netanyahu ha molti nemici e praticamente nessun alleato. Ma può ancora una volta contare su Hamas, che esattamente come lo Stato ebraico non ha alcuna voglia di assecondare il piano Trump. La fase due, quella vera, durerà quindi a lungo. E quella trumpiana, salvo suicidi di Israele o di Hamas, sarà al massimo la “fase tre”. O, il che è lo stesso, la “fase uno” della guerra, non per forza combattuta, tra Turchia e Stato ebraico.
Giuseppe DE RUVO – Dottorando in Filosofia morale allo European Center for Social Ethics (Ecse) dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Collaboratore di Limes.





